Ho
finito ieri Infinite Jest. Non credo sia un lavoro da cinquantenni leggerlo. C’è
qualcosa di così giovane, in fondo, di così irrisolto, che spiazza, intenerisce
ma anche infastidisce.
È
un colossale esercizio di bravura, con dentro una gran quantità di dolore che
lo rende autentico. Mi è piaciuto? A tratti è indimenticabile, non c’è dubbio. Ma
c’è qualcosa che non quadra, qualcosa di indefinibile, come se realmente il
fulcro di tutto fosse ( come si evince dal titolo) uno scherzo infinito, inutile,
che non fa ridere (nonostante in molti punti DFW crei situazioni che strappano involontariamente
risate fragorose).
Immergersi
in IJ è come fare un lungo, lunghissimo sogno, a tratti densissimo, a tratti
magnifico, ma che una volta svegli cessa completamente di avere importanza. Esci
da IJ con il desiderio di respirare, come dopo una lunga apnea: respirare e
guardarti intorno, lasciandoti assorbire dalla tua quotidiana realtà. È come se fossi appena scappato da dentro al
cervello in ebollizione di qualcuno che non sei tu. In ogni pagina pare di
sentire il flusso inarrestabile di una fantasia poderosa, sostenuta da una enorme
follia razionale. Mai un’opera lascia intravedere, come IJ, l’interno del
cervello di chi l’ha concepita. In questo DFW è unico tra i, diciamo, contemporanei.
È a livello di P. K. Dick,, Kafka, Beckett. Vite intese come letteratura, nel
bene e nel male.
È
un libro che tuttavia lascia un leggero retrogusto di insoddisfazione: non per
il finale – non finale, non per la struttura più o meno circolare e
frammentaria (a cose così un lettore abituale è preparato), ma per l’insensatezza generale del tutto.
Non
che le opere letterarie debbano avere senso, non che il concetto stesso di
senso abbia senso: non si richiede a Beckett di avere senso, ad esempio. No, il punto di Infinite Jest è che, pur
essendo molto bello in molti punti, pur avvincendoti in modo
incredibile, pur ammirando la maestria indiscutibile di DFW (maestria spesso
molto vicina all’esibizionismo), la sensazione che ne rimane, dopo il mesetto
di frequentazione con quel mattone dalla copertina azzurra, è vuoto.
Il
libro è un enorme contenitore vuoto: oserei dire, vuoto in maniera angosciante.
Attenzione, vuoto non è un giudizio estetico, né etico. Vuoto è vuoto. Un vuoto che attrae, insano. Nel fondo
di tutto il romanzo c’è un senso di tristezza, un qualcosa di tremendo che
lascia sconsolati e vuoti e freddi, qualcosa che solo la compassione, e solo a
tratti, può sperare di raggiungere. In fondo non parla d’altro che dei tanti
mezzi e trucchi approntati da varia umanità per cercare di continuare a vivere,
quando in realtà non ne ha nessuna voglia. Si vive sostituendo una dipendenza a
un’altra dipendenza, perché fuori da essa c’è solo la morte.
Il
vuoto è quello di chi si agita freneticamente e rimane sempre allo stesso punto:
una descrizione perfetta dell’inferno della depressione e dell’abuso di
sostanze in cui DFW ha dovuto vivere per tutta la sua vita.
È
un romanzo profondamente personale e, come tutte le opere profondamente
personali, si rovescia nell’universale: dentro la testa di DFW (IJ è la testa
di DFW, senza dubbio) ognuno può vedere riflesso sé stesso, in qualche modo. Questo
può essere uno dei motivi del grande successo di IJ, se ne vogliamo trovare uno:
un altro motivo può essere che è un libro che, se ti lasci prendere, ti
risucchia. Conosce i trucchi per indurre dipendenza e non c’è niente come il Disagio
Mentale che attrae, specie in quest’epoca, come l’Intrattenimento letale creato
da JOI.
Slavoj
Žižek dice in una delle sue ipercinetiche sputacchianti digressioni su Youtube:
perché essere felici, quando si può
essere interessanti?
La
volontà di essere interessante, a
qualunque prezzo, permea tutto IJ. E ci riesce spesso, ad esserlo. Non c’è un
vero desiderio di felicità, nel libro, quasi
fosse una parola sconosciuta. Tutto è, anzi, molto triste. Le miriadi di
personaggi che costellano il libro si muovono come caricature pavloviane,
agitate nella caccia alla loro specifica Sostanza. Le caricature si susseguono
alle caricature, partorite dalla fantasia inesauribile di DFW, quasi un
compendio di quella che potrebbe essere una delle innumerevoli e interminabili
sit – com americane. Tutto il libro lo è, in fondo: una sit – com di altissimo
livello.
IJ
smaschera la Dipendenza per quello che è: desiderio di morte. E lo fa senza
giudizi morali: tratta la cosa per quello che è. Non c’è qualcosa di giusto, né
qualcosa di sbagliato. Non si sceglie, ci si finisce. Per uscirne ci si deve
Arrendere, motto degli AA. Bisogna Arrendersi a un Potere Superiore (Il Secondo
dei 12 Passi degli Alcolisti Anonimi) che non si sa se c’è: sostituire un Vuoto
con un Fantasma. Sostituire la dipendenza dalla Sostanza, con la dipendenza da quella
che per molti versi è una setta rigida, gli AA.
E funziona. Per molti funziona. Non c’è
perché. Non c’è libertà. La libertà uccide.
Si
può solo scegliere di Arrendersi.
Mentre
Tristram Shandy (di cui IJ è
pronipote postmoderno) opera circolarità e digressioni infinite allungando i
tempi, procrastinando per allontanare la fine e sfuggire alla morte, celebrando
la vita, IJ opera circolarità e attua eterne digressioni, perché è intrappolato
in qualcosa di morto, come lo spettro
di JOI che verso la fine del libro appare e cerca di parlare con il figlio
morto - dentro. Mentre tutti gli innumerevoli personaggi del libro sono in un
certo senso unidimensionali e bloccati nelle
loro idiosincrasie, i due protagonisti principali (Hal Incandenza e Don Gately) tentano di raggiungere la consapevolezza, unica forza che può spezzare
la corazza per potere uscire all’aperto. Non si sa, né si può intuire, se i
loro sforzi potranno essere vincenti. Resta forse uno spiraglio aperto,
posizionato molto oltre la fine del libro, una speranza che alla fine la
maledetta circolarità possa essere spezzata: una tenue speranza, di cui però non
sappiamo nulla.
IJ
descrive con una gigantesca vitalità, tesa ai limiti delle possibilità umane, il
desiderio di morte della nostra società. È il più colossale ossimoro mai creato
dalla letteratura. Una morte viva, quella dell’Intrattenimento letale. Una vita
morta, quella degli atleti ragazzini e dei disperati della casa di recupero. Il
meno che si possa dire di IJ è che è inquietante. È come se rappresentasse l’immenso
sforzo di far capire a degli zombie che si devono svegliare. Ma gli zombie non
dormono, sono non – vivi e non - morti. Lo sforzo non può avere successo che
con gli umani. E tanti sono i personaggi – zombie così, forse tutti, tranne
Mario, forse, eterno fanciullo, ma purtroppo ancora caricaturale nella sua quasi
scontata “santità”. Don Gately, ex ladro di appartamenti, ex alcolista e
dipendente da narcotici è l’unico personaggio del romanzo che, insieme ad Hal,
abbia ancora qualcosa di vivo, di umano. Sono umani attraverso il dolore. Entrambi abbracciano
la consapevolezza del dolore, unico mezzo attraverso il quale può, forse,
operarsi una rinascita.

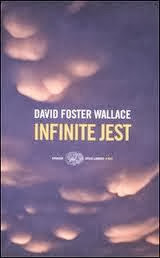
Ci voleva una tua recensione per incuriosirmi, e non poco (affetto come sono da prevenzione verso la letteratura a stelle e strisce, con rare eccezioni). A presto
RispondiElimina;-)
Neanche io sono un filoamericano, ma IJ è una rara eccezione, anche se non mi sento di definirla un'opera completamente riuscita ...
Elimina"Immergersi in IJ è come fare un lungo, lunghissimo sogno, a tratti densissimo, a tratti magnifico, ma che una volta svegli cessa completamente di avere importanza".
RispondiEliminaVero, e si potrebbe dire anche di tanta filosofia contemporanea!
; - )
EliminaA quando un post su Thomas Pynchon e Cormac Mccarthy?
RispondiElimina